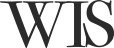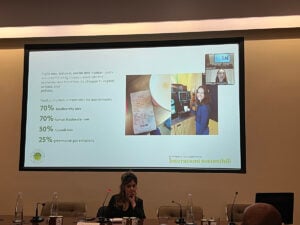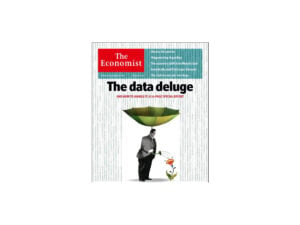Atmosfera vivace e costruttiva a Villa Zito. Il Simposio “Interazioni Sostenibili”, promosso dalla Fondazione SOStain Sicilia, ha raccolto studiosi, produttori, ricercatori, apicoltori, economisti, tecnici del territorio e giornalisti per ragionare insieme su un tema che ormai riguarda tutti: come rendere l’agricoltura, e la viticoltura in particolare, più resiliente davanti a un clima che cambia, a suoli fragili e a ecosistemi che chiedono di essere protetti.
Sin dalle prime battute, il messaggio è emerso con estrema chiarezza: il futuro non è altrove, lontano, ma qualcosa che si plasma ora, attraverso scelte concrete. Qui e adesso.
Il presidente della Fondazione, Alberto Tasca, ha aperto i lavori tornando a ciò che spesso dimentichiamo. Ogni minuto scompaiono nel mondo porzioni di foresta grandi quanto una trentina di campi da calcio e le emissioni globali seguono curve che raccontano un pianeta la cui febbre non smette di salire dagli anni ’50 del secolo scorso.
Ma il punto non è solo descrivere il problema. Tasca ha invitato a considerare la transizione come un investimento che ripaga: ogni euro dedicato a prevenzione e resilienza può generarne molti di più, sia in termini ambientali sia economici. La rete SOStain, costituita da 43 aziende associate, 33 certificate, oltre 6.300 ettari di vigneto sostenibile, dimostra che un modello diverso non è un’utopia, ma un percorso già in atto.
Tra gli interventi più coinvolgenti c’è stato quello di Luca Mercalli, climatologo, divulgatore scientifico e presidente della Società Meteorologica Italiana, collegato da Torino. Ha scelto di non prendere l’aereo per coerenza con le proprie convinzioni e il proprio stile di vita, e questa scelta, più delle parole, ha dato misura del suo messaggio. Mercalli ha spiegato cosa significhi un aumento potenziale della temperatura fino a +5°C entro la fine del secolo: estati più dure, incendi, desertificazione, difficoltà di approvvigionamento idrico, trasformazioni profonde degli ecosistemi. Una prospettiva che appare lontana solo a chi non guarda la cronaca degli ultimi anni. Eppure, ha ricordato, restano margini per contenere i danni se si adotta rapidamente un modello energetico basato sulle rinnovabili e su un uso più responsabile delle risorse.
La forza del Simposio è stata la capacità di coniugare analisi scientifiche e casi reali. Un esempio arriva dalla ricerca sul peso delle bottiglie, un tema che riguarda un pezzo importante dell’impronta ambientale del vino. Qui è entrata in gioco O-I, uno dei maggiori produttori mondiali di contenitori in vetro e partner tecnico della Fondazione. Insieme alle aziende SOStain, O-I ha analizzato oltre dieci milioni di bottiglie prodotte da otto cantine certificate. Il risultato racconta molto più di una semplice scelta estetica.
Il disciplinare SOStain chiede che le bottiglie da 0,75 litri non superino i 550 grammi; la ricerca ha mostrato che questo obiettivo è non solo raggiungibile, ma capace di generare effetti concreti. La riduzione del vetro utilizzato ha portato a un risparmio stimato di 726 tonnellate di CO₂ equivalente all’anno, quanto le emissioni di quasi 300 automobili. Inoltre, l’esperienza industriale di O-I ha aperto scenari inediti: bottiglie prodotte interamente in Sicilia con vetro riciclato, logistica più corta, tassi di riciclo fino al 90%. Una combinazione che potrebbe far scendere l’impronta carbonica a 0,42 kg di CO₂ per bottiglia. Un traguardo che va oltre la tecnologia: racconta un territorio capace di chiudere i cicli e trasformare il vetro in un volano di competitività sostenibile.
Non meno interessante lo scenario delle bottiglie “100% Sicilia”, prodotte con vetro riciclato e filiere logistiche più corte: con un tasso di riciclo vicino al 90% e distanze medie di trasporto ridotte, l’impronta carbonica per bottiglia scenderebbe a 0,42 kg di CO₂. Un risultato che potrebbe trasformare l’isola in un laboratorio avanzato di innovazione nel packaging.
Il racconto della sostenibilità, però, non si esaurisce nella tecnologia. C’è un’altra voce che ha lasciato il segno: quella delle api. Il progetto “Honeybees & Vineyard”, avviato con il supporto della FAI (Federazione Apicoltori Italiani) e di Intesa Sanpaolo, ha riportato colonie di api siciliane nei vigneti delle aziende SOStain. Cinquanta alveari, dieci apicoltori, 6,3 milioni di api attive: numeri che rivelano un lavoro paziente. Tra maggio e ottobre – racconta Raffaele Cirone, presidente dell’associazione – questi insetti hanno raccolto migliaia di chili di nettare e polline, percorrendo complessivamente cinquanta milioni di chilometri. Le analisi sui campioni hanno raccontato una biodiversità ricca, oltre venti specie botaniche, e soprattutto l’assenza di pesticidi e metalli pesanti. Le api sono diventate sentinelle, custodi silenziose della salute dei vigneti.
Anche la tecnologia digitale ha trovato spazio nella visione comune. Droni, satelliti, intelligenza artificiale, modelli previsionali: strumenti che, se integrati con competenze agronomiche ed esperienza sul campo, aiutano a gestire irrigazione, suoli, varietà e qualità delle uve in un clima sempre meno prevedibile. Una rete di capannine meteo, presto attiva su mille ettari di vigneti siciliani, permetterà di raccogliere dati preziosi per chi lavora la terra ogni giorno.
Sul fronte dell’energia, la Sicilia è stata descritta come un crocevia decisivo del Mediterraneo. Le analisi presentate hanno mostrato come gli obiettivi europei in materia di riduzione delle emissioni richiedano una visione condivisa, in cui agricoltura e imprese non restino ai margini delle scelte energetiche ma le interpretino da protagoniste. Il nuovo Piano Energetico Ambientale regionale va in questa direzione.
Accanto alle analisi tecnico-scientifiche, uno spazio speciale è stato dedicato alla comunicazione. Raccontare la sostenibilità non significa costruire slogan, ma ispirare fiducia. Chiara Patitucci ha invitato le aziende a un linguaggio che unisca trasparenza, coerenza e capacità di emozionare, perché una comunità informata tende a compiere scelte più responsabili.
A completare il mosaico, diversi esempi di economia circolare: dall’impianto di Assoro Biometano, che produce biometano da scarti agroalimentari, alla filiera del sughero raccontata da Amorim Cork Italia. Tutti casi che mostrano come un rifiuto possa trasformarsi in risorsa se esiste una visione capace di tenere insieme imprese e territori.
Nota: l’articolo “The Data Deluge” di The Economist (2010), brevemente accennato durante il Simposio, descrive la crescente produzione mondiale di informazioni e il modo in cui questo fenomeno stia cambiando il lavoro di imprese, governi e ricercatori. L’attenzione si sposta dalla quantità dei dati alla capacità di leggerli, selezionarli e trasformarli in decisioni sensate. La gestione diventa cruciale: archiviazione, qualità, analisi e sicurezza richiedono competenze nuove e infrastrutture adeguate. Il testo mette in evidenza il valore strategico dei dati nei settori più diversi, dalla scienza alla pubblica amministrazione, dal commercio alla gestione delle risorse. Accanto alle opportunità emergono interrogativi etici legati alla privacy e alla tutela delle persone. Chi saprà interpretare questo flusso informativo potrà migliorare servizi, prevenire rischi e orientare meglio le proprie scelte. Un tema che oggi appare ancora più attuale e che dialoga con tutte le sfide della sostenibilità.