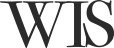La Francia è da sempre un mosaico di varietà di vite. Due millenni di storia, dai romani, ai cistercensi, più un milennio anni di cultura contadina, hanno selezionato vitigni diversi per ogni regione, capaci di esprimere caratteri unici nei vini. Poi, alla fine dell’Ottocento, la fillossera – un minuscolo insetto arrivato probabilmente da regioni centrali e orientali degli Stati Uniti – devastò il vigneto europeo. Tutto. Ricostruire fu un’impresa titanica e avvenne a caro prezzo: per salvare la produzione si reimpiantarono poche varietà, quelle considerate più produttive e resistenti, trascurando una miriade di uve locali.
Con il tempo, le norme per le denominazioni di origine, nate per tutelare la qualità, finirono per restringere ulteriormente il campo. Dal 1919 in poi, solo alcune varietà “riconosciute” potevano entrare nei vini a marchio territoriale. Nel giro di pochi decenni, oltre 500 vitigni storici sparirono dalle vigne francesi: alcuni estinti, altri relegati a vecchie parcelle isolate o a filari dimenticati ai margini delle strade di campagna. Oggi il 95% del vigneto francese è composto da una ventina di vitigni principali.
Questa omogeneità, pur avendo garantito qualità e fama internazionale, ha ridotto la resilienza del sistema vitivinicolo: meno diversità genetica significa minore capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici, ai parassiti, alle nuove esigenze del gusto.
Eppure, nascosti tra rovi e muri diroccati, sopravvivono ancora antichi ceppi che nessuno ha più vinificato da generazioni. Alcuni crescono su vecchie pergole di case rurali, altri si arrampicano su alberi o spuntano in terreni abbandonati. A guardarli, sembrano solo relitti del passato. Ma il loro DNA custodisce aromi, resistenze naturali e tratti unici che l’enologia moderna ha quasi dimenticato.
Negli ultimi anni, una nuova sensibilità ha spinto ricercatori, vivaisti e vignaioli a cercare queste varietà “perdute”. Si parte spesso da indizi tramandati oralmente – “là, in quel pendio, c’era un’uva dal colore strano…” – oppure da vecchi registri agricoli. Le spedizioni di ricognizione non sono semplici: molte viti sono malate o ormai inselvatichite, il materiale vegetale richiede un lungo lavoro di pulizia e selezione sanitaria prima di poter essere propagato. Non è semplice: infatti, una volta recuperata, ogni pianta viene analizzata. Occorrono anni per identificarla, capire se è davvero una varietà distinta, e infine inserirla nei cataloghi ufficiali che ne permettono la coltivazione commerciale. In certi casi, i vignaioli ottengono permessi speciali per testare le uve su piccole superfici, producendo micro-vinificazioni sperimentali che riportano alla luce profumi dimenticati.
La rinascita dei vitigni dimenticati non è solo un fatto tecnico. È un atto culturale e identitario: significa restituire alla viticoltura la ricchezza che la storia e le leggi avevano compresso. Significa offrire ai consumatori vini diversi, sorprendenti, capaci di raccontare un territorio in modo nuovo e antico allo stesso tempo. Non si tratta di nostalgia, ma di futuro: un vigneto più vario è un vigneto più forte, capace di affrontare sfide come il cambiamento climatico e le malattie senza sacrificare l’autenticità. Ogni anno, nuove scoperte arricchiscono questo patrimonio. Nei laboratori, nelle collezioni ampelografiche e tra i filari sperimentali, le viti “scomparse” tornano lentamente a respirare. Non tutte diventeranno grandi vini da mercato, ma ciascuna rappresenta un tassello di memoria agricola e un’opportunità per il domani.
Conclusione:
Recuperare un vitigno è come ritrovare un dialetto dimenticato: non basta pronunciarlo, bisogna ridargli voce, ascoltarne le sfumature, lasciarlo vivere. E forse, tra qualche anno, nei calici dei nuovi appassionati, brinderemo a questi ritorni insperati, sorseggiando il gusto raro di un passato che si credeva perduto.
(la prossima volta parleremo della Sicilia)
FP
Fonti: Patrimoine ampélographique français et cépages «oubliés». Des innovations variétales compatibles avec une tradition pour lutter contre l’érosion génétique. Di Olivier Yobrégat, Institut français de la Vigne et du Vin – Pôle Sud-Ouest – Lisle-sur-Tarn – France /Revue des œnologues n° 159, avril 2016.